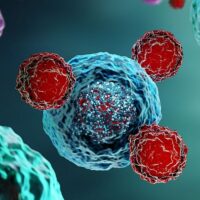Leucemia linfoblastica acuta a cellule B: identificata una sottopopolazione di cellule leucemiche “simil-staminali” in grado di favorire la prognosi della malattia
Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B. Tuttavia, la malattia in alcuni casi persiste dando vita a recidive il cui trattamento è complesso. Capire perché in alcuni casi la malattia resiste ai trattamenti e come poter indirizzare efficacemente e rapidamente le terapie più adatte al singolo paziente è stato uno degli obiettivi che si sono posti i medici e ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, SR-Tiget e Università Vita-Salute San Raffaele con lo studio pubblicato su “Leukemia”.
La ricerca, svolta grazie al sostegno di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, si è avvalsa di innovative tecniche di sequenziamento del RNA su singola cellula e studi di transcrittomica in collaborazione con i bioinformatici. Lo studio è stato condotto sia su campioni pediatrici che adulti, in collaborazione con il Centro Tettamanti, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
La leucemia linfoblastica acuta è un tumore del sangue che origina da particolarie globuli bianchi, i linfociti, e si caratterizza per un accumulo di queste cellule nel midollo osseo, nel sangue e in altri organi.
La malattia si definisce “acuta” perché progredisce molto velocemente e in particolare nella LLA i linfociti B vanno incontro a una trasformazione tumorale: la cellula blocca la sua maturazione e comincia a riprodursi velocemente invadendo prima il midollo osseo e poi il sangue, raggiungendo poi anche linfonodi, milza, fegato e il sistema nervoso centrale.
Seppur la LLA è una malattia relativamente rara, risulta il tumore più frequente in età pediatrica, esso rappresenta infatti l’80% di tutte le leucemia e il 25% di tutti i tumori diagnosticati tra gli 0 e i 14 anni.
Grazie all’avanzamento delle conoscenze e alle cure disponibili, in particolare le immunoterapie, oggi la prognosi di pazienti con LLA è molto migliorata rispetto al passato.
Tuttavia, alcuni pazienti presentano recidive e sono proprio le cellule che persistono al trattamento iniziale, definite nel loro insieme Malattia Minima Residua o Minimal Residual Disease in inglese, ad essere usate come fattore prognostico.
In che modo? Quanto minore è il numero di cellule leucemiche trovate al termine del primo trattamento (MRD basso), tanto migliore è la risposta del paziente al trattamento e minore è il rischio di ricaduta. Al contrario, più alta è la MRD, maggiore è la probabilità di recidiva.
Quantificare la malattia minima residua è quindi uno strumento fondamentale per stratificare i pazienti e aggiustare il trattamento ad hoc per ciascuna categoria di pazienti.
Un altro aspetto importante che rimane da chiarire è come fanno le cellule leucemiche a sopravvivere al trattamento, cosa c’è alla base della malattia minima residua e come si trasforma poi in recidiva?
Nella leucemia mieloide acuta e cronica, la persistenza della malattia è spesso associata all’esistenza di cellule leucemiche staminali in grado di sopravvivere in una sorta di letargo, anche per lungo tempo, per poi “risvegliarsi” dando vita alla recidiva.
“Proprio recentemente il nostro laboratorio ha portato avanti uno studio in cui è stato dimostrato come un particolare microRNA, il miR-126, identifichi proprio queste cellule leucemiche staminali, responsabili della resistenza alla chemioterapia.
Nella leucemia linfoblastica acuta a cellule B si parla piuttosto di eterogeneità intra-tumorale: all’interno di un tumore coesistono multiple popolazioni cellulari che differiscono per genetica, funzioni ed epigenetica”, afferma il professor Bernhard Gentner, fino a poco tempo fa responsabile del Laboratorio di cellule staminali e leucemia dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica e ora docente presso l’Università di Losanna.
I ricercatori si sono chiesti se miR-126 potesse avere anche un ruolo: nel determinare l’eterogeneità intra-tumorale nella leucemia linfoblastica acuta dell’uomo; di conseguenza, anche nella persistenza della malattia dopo trattamento.
Per rispondere a questa domanda hanno utilizzato tecniche di ingegneria genetica per marcare le cellule leucemiche con un reporter fluorescente in grado di evidenziare potenziali sottopopolazioni simili alle staminali.
“Siamo rimasti sorpresi quando abbiamo visto che la maggior parte dei campioni di B-ALL esaminati conteneva una sottopopolazione ‘simil-staminale’, caratterizzata da un’elevata attività di miR-126″,spiega la dottoressa Carolina Caserta, post doc fellow dell’Unità Cellule staminali traslazionali e leucemia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
Lo studio delle proprietà funzionali di questa sottopopolazione LLA-B ha lasciato pochi dubbi sulla sua importanza: nei modelli animali ha mostrato una crescita molto aggressiva e resistente alla chemioterapia.
Ma esiste un modo più semplice per identificare questa sottopopolazione nei campioni clinici. Pertanto i ricercatori hanno condotto studi molecolari per cercare cambiamenti a livello di DNA e RNA a monte e a valle del miR-126, definendo, rispettivamente, un modello di metilazione del DNA e una firma trascrittomica che caratterizzano le sottopopolazioni ad alto contenuto di miR-126, che possano essere facilmente identificate mediante il sequenziamento dell’RNA su singola cellula.
“Nella seconda parte del nostro studio ci siamo occupati di capire come tutte le informazioni sperimentali ottenute potessero essere utilizzate in clinica. Abbiamo riscontrato che i pazienti con LLA-B in cui erano maggiormente rappresentate queste sottopopolazioni ad alto contenuto di miR-126 sono risultati più spesso positivi alla malattia minima residua dopo la chemioterapia”, spiega la dottoressa Silvia Nucera, ricercatrice e medico presso la Fondazione Tettamanti ed ex post-doc nel laboratorio del professor Gentner.
La proposta del gruppo di ricerca del San Raffaele è di introdurre questo test prognostico nella clinica in associazione agli attuali criteri perché questo permetterebbe di: avere una stratificazione iniziale più precisa dei pazienti; identificare dei candidati che trarrebbero maggiore beneficio da un approccio immunoterapeutico di prima linea.
“Attualmente per quantificare la MRD è necessario sottoporre il paziente alla chemioterapia e attendere almeno 1 mese. Invece i test che abbiamo sviluppato potrebbero essere eseguiti direttamente su campioni diagnostici prima dell’inizio del trattamento. Questo potrebbe, in futuro, permettere di evitare o ridurre la chemioterapia nei pazienti scarsamente responsivi risparmiando loro inutili tossicità, un deciso passo in avanti per migliorare le cure”, conclude il professor Gentner.